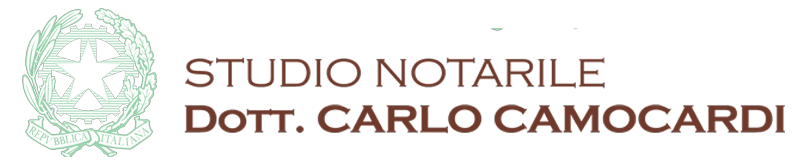1. Tema cruciale
La verifica dello stato legittimo è diventata negli ultimi anni uno dei passaggi più delicati nelle compravendite e negli interventi edilizi. Non è raro che, al momento di vendere un appartamento o richiedere un mutuo, emergano difformità edilizie non gravi – piccoli spostamenti di tramezzi, finestre realizzate con dimensioni diverse da quelle in progetto, errori grafici nelle planimetrie – ma sufficienti a generare incertezza e ritardi.
A ciò si aggiunge un dato strutturale: oltre il 40% degli immobili italiani ha più di 60 anni, secondo le stime richiamate nella Relazione illustrativa del decreto Salva casa. Questo significa che per una parte rilevante del patrimonio edilizio reperire i titoli originari di costruzione è un’impresa ardua, se non impossibile.
Il legislatore è quindi intervenuto con il d.l. 29 maggio 2024 n. 69, convertito nella l. 24 luglio 2024 n. 105 (c.d. decreto Salva casa), introducendo un nuovo criterio per determinare lo stato legittimo degli immobili. L’obiettivo è chiaro: semplificare la dimostrazione della regolarità urbanistica, rafforzare la certezza giuridica nelle transazioni e favorire la riqualificazione del patrimonio esistente.
Sia però ben chiaro sin da subito:
è una riforma che non incide sulla commerciabilità giuridica dei fabbricati ma sulla commerciabilità economica.
In altre parole: le regole che tuttora disciplinano tutti gli atti che trasferiscono la proprietà (o altro diritto reale) sui fabbricati non sono cambiate. Un fabbricato può essere, ad esempio, compravenduto anche se è viziato da abusi, più o meno gravi, di natura edilizia, pur incidendo questi sul suo valore commerciale e sulla responsabilità del venditore.
2. A che serve quindi lo “stato legittimo” di un fabbricato?
La nozione di stato legittimo non ha solo valore teorico: essa costituisce il parametro di riferimento di diverse disposizioni del Testo Unico Edilizia (TUE), dalle modalità di presentazione dei titoli abilitativi fino alla disciplina delle tolleranze costruttive.
2.1. Stato legittimo e mutamenti d’uso (art. 23-ter TUE)
L’art. 23-ter TUE disciplina il mutamento della destinazione d’uso urbanisticamente rilevante. La norma stabilisce che, ai fini della legittimità del cambio di destinazione, l’immobile debba essere conforme non solo agli strumenti urbanistici ma anche al proprio stato legittimo.
Conseguenza pratica:
- chi intende trasformare, ad esempio, un locale commerciale in abitazione, deve dimostrare che l’immobile sia conforme al titolo edilizio originario o all’ultimo titolo rilasciato sull’intero edificio.
- eventuali difformità non sanate possono precludere il cambio di destinazione, salvo ricorso agli strumenti di regolarizzazione previsti dal TUE.
2.2. Stato legittimo e dichiarazioni asseverate (art. 34-bis TUE)
L’art. 34-bis, introdotto dal d.l. 76/2020, consente al tecnico abilitato di attestare, con dichiarazione asseverata, la legittimità di alcune difformità minori (le c.d. tolleranze costruttive).
La dichiarazione tecnica ha valore non solo nei rapporti con il Comune ma anche ai fini civilistici, potendo essere allegata agli atti di trasferimento immobiliare.
La riforma del 2024 rafforza il collegamento tra attestazione tecnica e stato legittimo: la dichiarazione del professionista diventa uno strumento privilegiato per documentare la conformità dell’immobile, riducendo il rischio di contestazioni future.
2.3. Stato legittimo e tolleranze esecutive (art. 34-ter TUE)
L’art. 34-ter, anch’esso introdotto nel 2020, disciplina le tolleranze esecutive, cioè quelle difformità di minima entità che non costituiscono abuso edilizio.
Esempi:
- irregolarità geometriche o di misure contenute entro il 2%;
- modifiche interne di limitata entità;
- errori grafici di rappresentazione progettuale.
Tali difformità non incidono sullo stato legittimo e possono essere dichiarate dal tecnico, con valore probatorio anche nei contratti.
2.4. Effetto sistemico della riforma del 2024
Con il decreto Salva casa, il concetto di stato legittimo si rafforza come architrave dell’intero sistema edilizio:
- parametro per l’attività edilizia futura (mutamenti d’uso, ristrutturazioni, nuove autorizzazioni);
- presupposto per la validità delle dichiarazioni tecniche asseverate.
3. Di che norme parliamo
3.1. L’art. 9-bis TUE
Con il decreto semplificazioni del 2020 (d.l. 76/2020, conv. l. 120/2020) il legislatore introduce, all’art. 9-bis, comma 1-bis TUE, la definizione di “stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare”.
Secondo la formulazione di allora:
- lo stato legittimo derivava dal titolo edilizio che aveva autorizzato la costruzione o che l’aveva successivamente legittimata;
E
- dal titolo che aveva disciplinato l’ultimo intervento edilizio sull’intero immobile, integrato da eventuali titoli parziali.
La logica era quella di fornire un criterio certo e uniforme, sostituendo le prassi difformi che i Comuni avevano nel tempo elaborato per attestare la regolarità edilizia.
3.2. La giurisprudenza costituzionale: uniformità nazionale
Con la sentenza 217/2022, la Corte costituzionale ha confermato che i criteri di determinazione dello stato legittimo costituiscono principio fondamentale del governo del territorio (art. 117, comma 3, Cost.).
Ne consegue che:
- la materia non può essere disciplinata autonomamente dalle Regioni;
- le norme statali hanno valore vincolante sull’intero territorio nazionale;
- la finalità è duplice: semplificare l’azione amministrativa e assicurare certezza alla circolazione dei diritti immobiliari.
La Consulta ha inoltre chiarito che solo il titolo edilizio può costituire base dello stato legittimo, escludendo che documenti diversi, come i certificati di agibilità o abitabilità, possano sostituirlo. Questi ultimi attestano condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, ma non equivalgono a prova di conformità edilizia.
4. La riforma del 2024: la nuova conformazione dello stato legittimo
Con il Salva Casa il legislatore è intervenuto in modo incisivo sull’art. 9-bis TUE, riformulando il comma 1-bis e ridefinendo la nozione di stato legittimo.
La novità principale consiste nell’introduzione di un criterio alternativo di attestazione:
- lo stato legittimo può essere dimostrato dal titolo abilitativo originario che ha previsto o legittimato la costruzione dell’immobile;
OPPURE
- dall’ultimo titolo edilizio rilasciato o assentito sull’intero immobile, a condizione che l’amministrazione, in sede di rilascio, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi.
In entrambi i casi, la ricostruzione resta completata dagli eventuali titoli parziali intervenuti nel tempo.
4.1. Alternatività “condizionata”
Non si tratta di una libertà piena: l’alternativa è subordinata a una condizione precisa. Perché l’ultimo titolo edilizio possa assolvere alla funzione di attestazione dello stato legittimo, è necessario che l’amministrazione comunale, nel rilasciarlo, abbia effettivamente verificato i titoli precedenti; occorre che vi sia stata una verifica concreta e sostanziale da parte dell’ufficio tecnico.
La Relazione al decreto chiarisce il senso della riforma: tutelare l’affidamento del privato. Se l’amministrazione, in passato, ha rilasciato un permesso di costruire nonostante piccole difformità non considerate rilevanti, non potrà successivamente contestare l’assenza di stato legittimo sull’immobile.
Quindi, l’aspetto innovativo e di rilievo è che, in presenza di difformità non rilevate al momento del rilascio del titolo edilizio, non può negarsi lo stato legittimo: ciò costituisce una vera e propria forma di “preclusione” all’azione amministrativa tardiva, con importanti riflessi anche sul piano processuale.
4.2. Le due vie di prova dello stato legittimo
Possiamo quindi distinguere due percorsi:
- Titolo originario → valido per chi riesce a reperire la licenza edilizia, concessione o permesso che ha legittimato la costruzione, eventualmente integrato dai titoli successivi.
- Ultimo titolo sull’intero immobile → utilizzabile quando il Comune, nel rilasciarlo, ha controllato i titoli precedenti, consentendo al privato di evitare la ricostruzione storica completa.
In entrambi i casi, eventuali difformità parziali non contestate in passato non potranno costituire motivo di assenza di stato legittimo.
5. I titoli edilizi e le questioni aperte
La definizione di stato legittimo ruota attorno al concetto di “titolo edilizio”. Tuttavia, la disciplina incontra diverse complessità, legate all’evoluzione normativa e alla vetustà di buona parte del patrimonio edilizio italiano.
5.1. Quali titoli sono idonei?
Rientrano certamente tra i titoli abilitativi rilevanti:
- la licenza edilizia (introdotta dalla l. 1150/1942, resa obbligatoria in tutto il territorio comunale con la c.d. legge ponte, l. 765/1967, in vigore dal 1° settembre 1967);
- la concessione edilizia (l. 10/1977, c.d. legge Bucalossi);
- il permesso di costruire (oggi disciplinato dall’art. 10 TUE);
- le SCIA e CILA, per gli interventi che ne sono oggetto.
Sono invece esclusi, come precisato anche dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale, documenti di altra natura quali il certificato di agibilità o abitabilità, che attesta condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, ma non surroga il titolo edilizio.
5.2. Immobili realizzati prima del 1967
Il nodo principale riguarda gli immobili costruiti prima del 1° settembre 1967, data di entrata in vigore dell’obbligo generalizzato della licenza edilizia anche fuori dai centri abitati.
- Fino al 1942, l’obbligo di licenza esisteva solo in alcune zone, secondo i regolamenti comunali.
- Con la l. 1150/1942, l’obbligo si estende ai centri abitati e, per i Comuni dotati di piano regolatore, anche alle zone di espansione.
- Solo con la l. 765/1967 la licenza diventa necessaria per qualsiasi nuova costruzione su tutto il territorio comunale.
Ne consegue che per gli edifici anteriori al 1967, costruiti fuori dai centri abitati o in assenza di regolamenti comunali, lo stato legittimo può essere attestato sulla base della documentazione storica disponibile (fotografie, mappe catastali, atti d’epoca).
5.3. Immobili realizzati dopo il 1967: dispersione dei titoli
Diversa la situazione per gli immobili edificati successivamente al 1967 (o anche prima in caso di adozione di regolamenti comunali). Qui la principale difficoltà è la dispersione dei titoli originari:
- i documenti possono non essere reperibili per deterioramento o perdita degli archivi comunali;
- spesso le copie non sono state conservate dai privati;
- gli uffici tecnici operano in condizioni di cronica difficoltà nel ricostruire pratiche molto datate.
In tali casi, la riforma del 2024 offre una via di uscita: l’ultimo titolo edilizio sull’intero immobile, se rilasciato previa verifica dei titoli pregressi, può valere come prova dello stato legittimo, evitando ricerche archivistiche spesso infruttuose.
5.4. L’inesistenza di copie e la prova documentale
Il legislatore ha recepito l’indirizzo del Consiglio di Stato (sent. 1565/2017), secondo cui la pubblica amministrazione può basarsi anche su un principio di prova e non necessariamente su documentazione integrale.
In particolare, per attestare la legittimità di immobili costruiti in epoche risalenti possono bastare:
- atti di compravendita con menzioni edilizie,
- mappe catastali storiche,
- certificazioni d’epoca,
- dichiarazioni tecniche asseverate.
Il punto cruciale è che la ricostruzione non può gravare interamente sul privato, ma deve avvenire con la collaborazione dell’amministrazione, chiamata ad acquisire d’ufficio quanto già nei suoi archivi.
6. Lo stato legittimo negli edifici con più unità immobiliari
La nozione di stato legittimo acquista una particolare complessità quando si tratta di edifici composti da più unità immobiliari, come avviene nella quasi totalità dei condomini urbani.
6.1. La questione di fondo
Il problema nasce dalla necessità di distinguere:
- da un lato, lo stato legittimo dell’intero edificio, che costituisce il “contenitore” edilizio;
- dall’altro, lo stato legittimo delle singole unità immobiliari, ciascuna con eventuali interventi autonomi nel tempo.
La giurisprudenza e la dottrina hanno chiarito che, sebbene ogni unità possa essere oggetto di titolo autonomo (ad esempio una CILA per modifiche interne), essa resta pur sempre inserita in un organismo edilizio unitario, la cui legittimità complessiva deve essere verificata.
6.2. Il criterio introdotto dall’art. 9-bis
Il legislatore, con la riforma del 2020 e poi con il decreto Salva casa, ha individuato due criteri distinti ma integrabili:
- Titolo originario dell’edificio → rilevante per attestare la conformità dell’intero fabbricato.
- Titoli parziali → riferiti alle singole unità, che si sommano e si integrano al primo.
Ciò significa che il titolo relativo a un appartamento non può prescindere dal titolo dell’edificio nel suo complesso.
6.3. Esempio concreto
Immaginiamo un condominio costruito nel 1970 con regolare licenza edilizia. Negli anni successivi:
- il singolo condomino A realizza nel 1990 modifiche interne con una DIA;
- il condominio nel 2005 ottiene un permesso di costruire per ristrutturazione complessiva.
In base alla riforma del 2024, lo stato legittimo dell’intera costruzione può essere oggi provato attraverso il permesso del 2005, a condizione che il Comune, nel rilasciarlo, abbia verificato la regolarità dei titoli precedenti (1970 e 1990). Questo consente di evitare di ricostruire puntualmente la pratica del 1970.
6.4. Profili problematici
Non mancano, tuttavia, questioni ancora dibattute:
- Frazionamenti e unità autonome: quando un immobile plurimo è stato frazionato in più unità, occorre verificare se l’intervento sia stato accompagnato da titolo edilizio, altrimenti può generare difformità sostanziali.
- Unità con abusi isolati: se una singola unità presenta difformità non sanate, lo stato legittimo dell’edificio non copre automaticamente l’irregolarità della porzione. In questo caso la commerciabilità dell’unità può essere compromessa.
7. La dichiarazione asseverata e le tolleranze costruttive
7.1. Le tolleranze costruttive: una risposta a un problema diffuso
Chi opera nel settore immobiliare sa che raramente un edificio viene realizzato in perfetta corrispondenza con i progetti depositati.
Piccoli scostamenti geometrici, errori grafici nelle planimetrie, lievi modifiche esecutive costituiscono la regola, più che l’eccezione.
Per risolvere questo problema è stato introdotto l’art. 34-bis TUE (tolleranze costruttive), poi integrato dall’art. 34-ter TUE (tolleranze esecutive).
7.2. Differenza tra tolleranze costruttive ed esecutive
- Tolleranze costruttive (art. 34-bis): riguardano modifiche di dettaglio che si manifestano in corso d’opera e che non incidono sulla conformità complessiva (ad es. lo spostamento di un tramezzo, una finestra leggermente più larga).
- Tolleranze esecutive (art. 34-ter): sono deviazioni minime dai progetti autorizzati, quantificate percentualmente (es. scostamenti dimensionali entro il 2%).
In entrambi i casi, non si tratta di abusi edilizi ma di irregolarità non rilevanti, che non impediscono di considerare l’immobile conforme.
7.3. Il ruolo del tecnico abilitato
La legge attribuisce ai tecnici abilitati (ingegneri, architetti, geometri) il compito di attestare, con dichiarazione asseverata, l’esistenza di tolleranze.
Questa asseverazione ha valore probatorio qualificato:
- produce effetti verso la pubblica amministrazione;
- può essere allegata agli atti notarili di trasferimento;
- rafforza la certezza nella circolazione immobiliare, evitando che difformità minime generino nullità o contestazioni.
Lo Studio CNN 225-2024 sottolinea che la dichiarazione asseverata assume rilievo non solo urbanistico ma anche civilistico, potendo integrare la documentazione necessaria per attestare lo stato legittimo.
7.4. Esempi pratici
- Esempio 1: Difformità grafica
In un appartamento, il vano bagno è rappresentato in planimetria con dimensioni di 2,00 x 2,50 metri, ma nella realtà misura 2,05 x 2,45. Il tecnico attesta che lo scostamento rientra nella tolleranza esecutiva. L’immobile resta conforme, senza necessità di sanatoria.
- Esempio 2: Spostamento di tramezzo
Un tramezzo interno è stato realizzato con uno scostamento di 10 cm rispetto al progetto. Il tecnico certifica la tolleranza costruttiva. Lo stato legittimo dell’unità resta intatto.
- Esempio 3: Finestra di diversa dimensione
La finestra della cucina è stata realizzata con apertura di 1,25 m anziché 1,20 m. L’asseverazione tecnica la qualifica come tolleranza. In sede notarile, l’atto di vendita può essere stipulato senza riserve.
Per approfondimenti contatta pure lo Studio Notarile Carlo Camocardi.